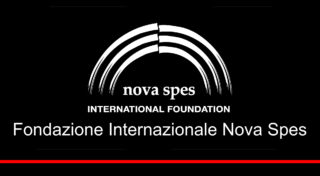Laura Paoletti – GENERATO, NON CREATO: TECNOLOGIA IN CERCA D’AUTORE
(Editoriale di Paradoxa 4/2023) Ho chiesto a uno dei volti più noti dell’intelligenza artificiale generativa (ChatGPT) se conoscesse l’espressione «generato, non creato». Mi ha spiegato che è un sintagma proprio della teologia cristiana e che – copio e incollo la risposta – «in questo contesto ‘generato’ si riferisce al fatto che il Figlio è nato o ha avuto origine dal Padre, ma non è stato creato nel senso di essere stato creato ex nihilo (dal nulla) come il resto del creato». Chapeau. È assai improbabile che, rivolgendo la stessa domanda all’uscita di una chiesa di culto cattolico, dove ogni domenica i fedeli professano nel Credo questo articolo di fede, si otterrebbe una risposta altrettanto precisa nel restituire senza fronzoli la posta in gioco del punto in questione, nello specifico la salvaguardia dell’identità sostanziale tra le persone della Trinità. È altrettanto improbabile, però, che ChatGPT abbia colto la maliziosità della domanda: ma non anticipiamo. Anche volendosi atteggiare a navigati fruitori di tecnologia, sarebbe difficile negare che interazioni di questo tipo – cui faremo, volenti o nolenti, l’abitudine – suscitano ad oggi uno stupore che è in bilico tra l’ammirazione e l’inquietudine. Le pagine che seguono scavano a fondo in questa ambivalenza,