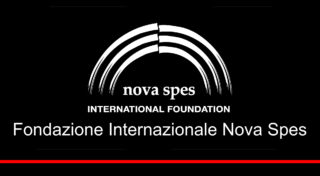Stefano Quintarelli – LA METAFORA DELL’INTELIGENZA ARTIFICIALE: LIMITI E POTENZIALITA’
(Estratto da Paradoxa 4/2023) Sarà vera intelligenza? ‘Intelligenza artificiale’ è una metafora. Particolarmente azzeccata, date le numerose analogie che su di essa si possono basare, ma pur sempre una metafora. Quando conosciamo bene una cosa, i limiti delle metafore che la riguardano ci sono evidenti: non ci addentreremmo in speculazioni se ‘una montagna di libri’ sia o meno un ambiente adatto alla riproduzione degli stambecchi, anche se non si può escludere che qualcuno, in particolare attorno all’epoca di Gutenberg, possa averlo fatto. Lo slogan ‘intelligenza artificiale’ è nato il 2 settembre 1955, quando gli accademici chiesero alla Fondazione Rockefeller un finanziamento di 13500 dollari per poter svolgere un workshop estivo con una decina di scienziati, della durata di un paio di mesi, da tenersi nell’estate del 1956 presso l’Università di Dartmouth. I proponenti erano alcuni mostri sacri della matematica e dell’informatica dell’epoca: McCarthy, Minsky, Rochester e Shannon. Proponiamo che uno studio sull’intelligenza artificiale, della durata di due mesi e composto da dieci persone, venga condotto durante l’estate del 1956 al Dartmouth College di Hanover, nel New Hampshire. Lo studio deve procedere sulla base della congettura che ogni aspetto dell’apprendimento o di qualsiasi altra caratteristica dell’intelligenza possa essere descritto in linea