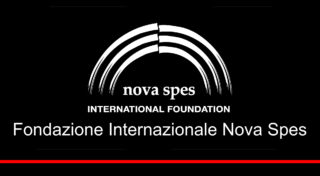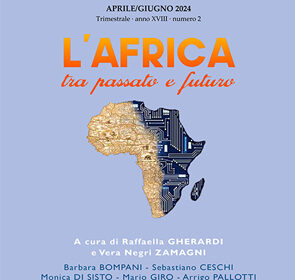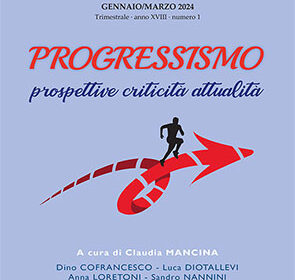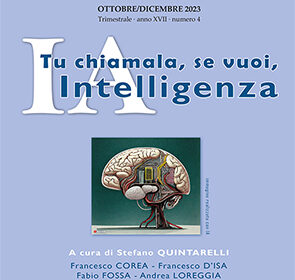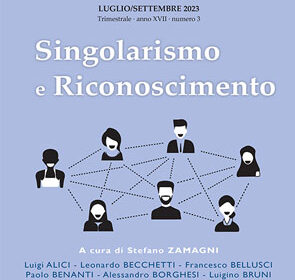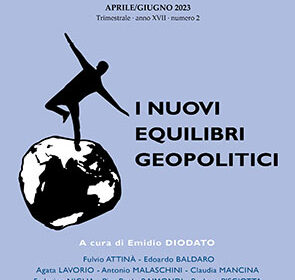Laura Paoletti – LA ‘NOSTRA’ AFRICA TRA DOGMA E MITO
(Editoriale di Paradoxa 2/2024) «Gli europei hanno perso la capacità di costruire miti o dogmi e quando ne abbiamo bisogno siamo dipendenti dalle reliquie del nostro passato. Ma la mente degli africani si muove con naturalezza e semplicità su questi sentieri oscuri e profondi» (K. Blixen, Out of Africa, Londra 2015). Il noto romanzo di Karen Blixen trabocca di affermazioni come questa, che descrivono con piglio sicuro tratti caratteristici e funzionamento della ‘mente’ africana; questa in particolare, però, nella sua involontaria paradossalità, è rivelativa come un atto mancato: nell’attribuire ai ‘nativi’ la capacità – che noi europei avremmo perduto – di muoversi sugli oscuri terreni del mito, infatti, tradisce la poderosa operazione di mitopoiesi con cui l’autrice reinventa, e così addomestica, l’estraneità di quella che diventa la ‘sua’ Africa. È un’operazione in certa misura inevitabile. Se, però, al mito per molti versi simile dell’ ‘orientalismo’, a partire dall’omonimo saggio di Edward Said del 1978, abbiamo imparato a guardare con cautela, quella della ‘nostra’ Africa è un’idea che attende ancora una piena demitizzazione. Le pagine che seguono offrono un contributo in questa direzione, decostruendo, dati alla mano, alcuni luoghi comuni particolarmente efficaci nel modellare il nostro immaginario. È interessante, per esempio,